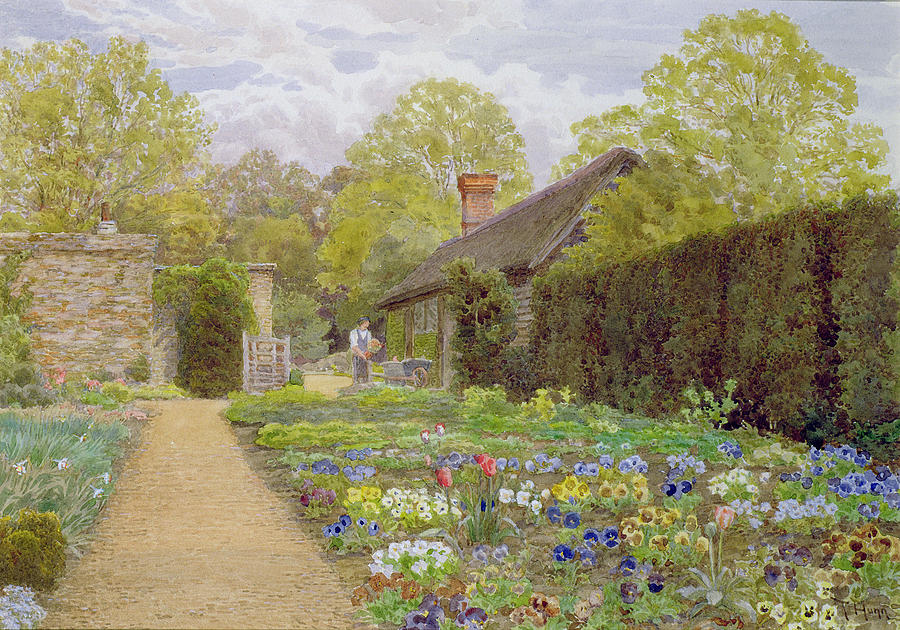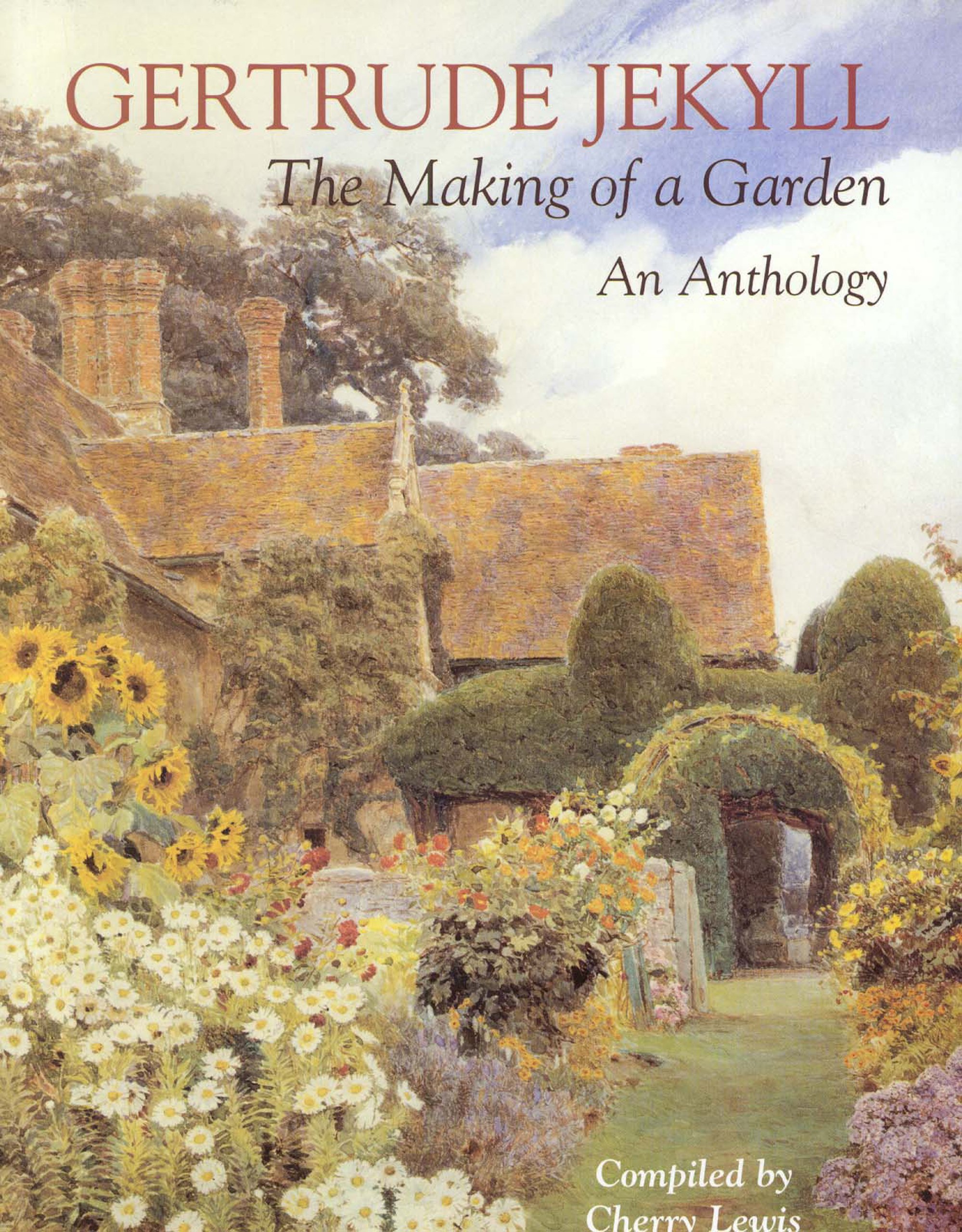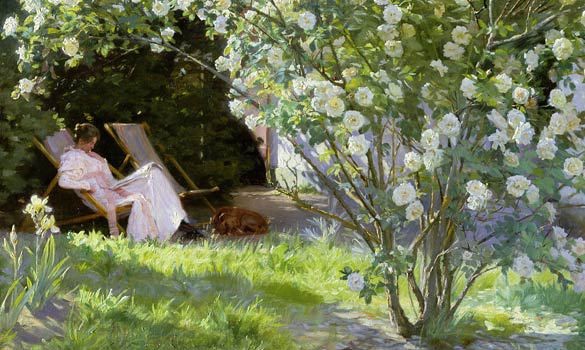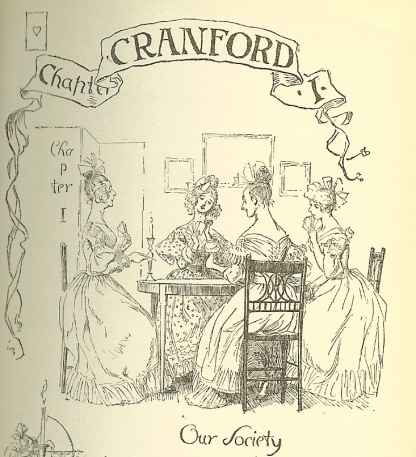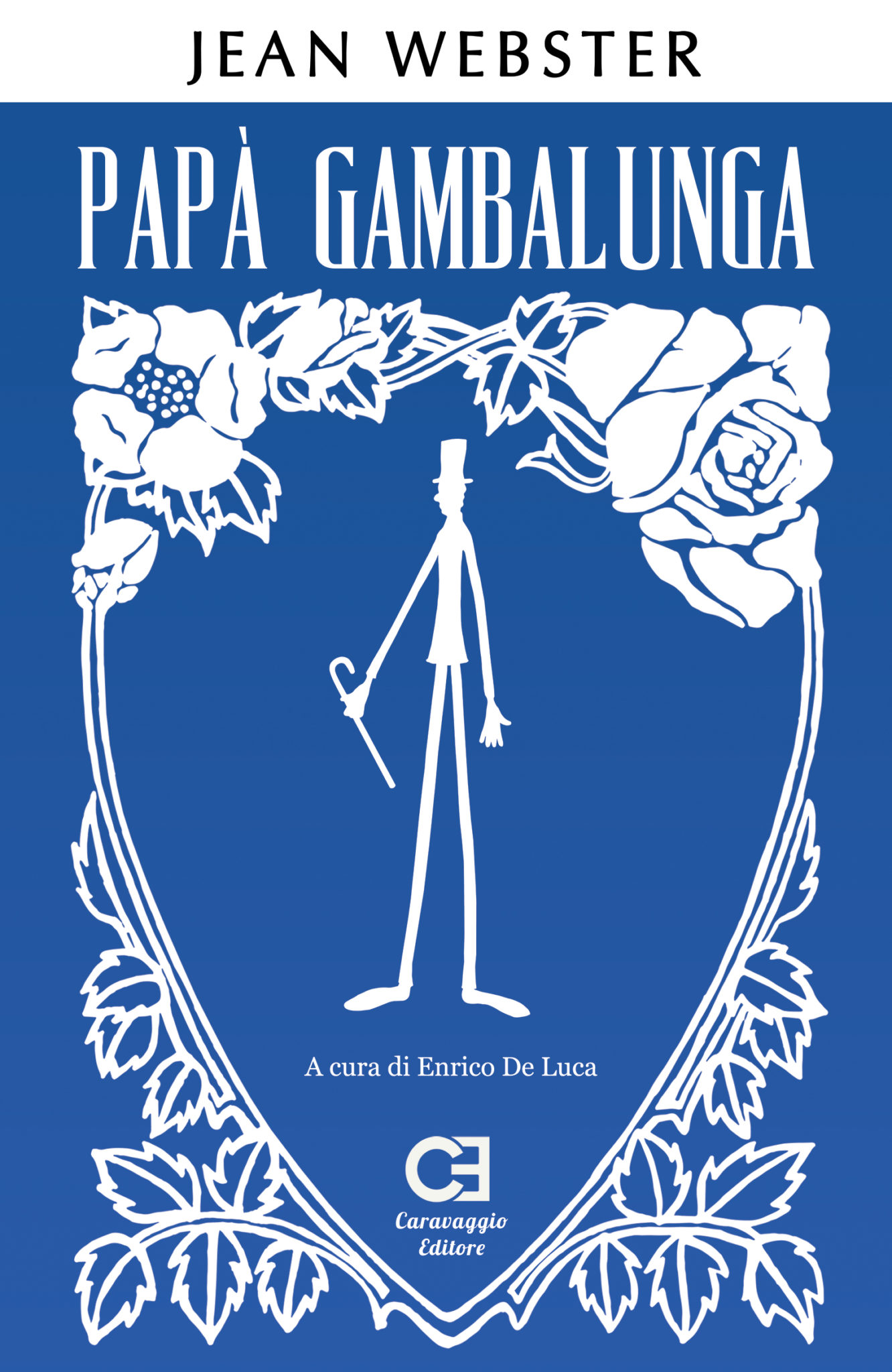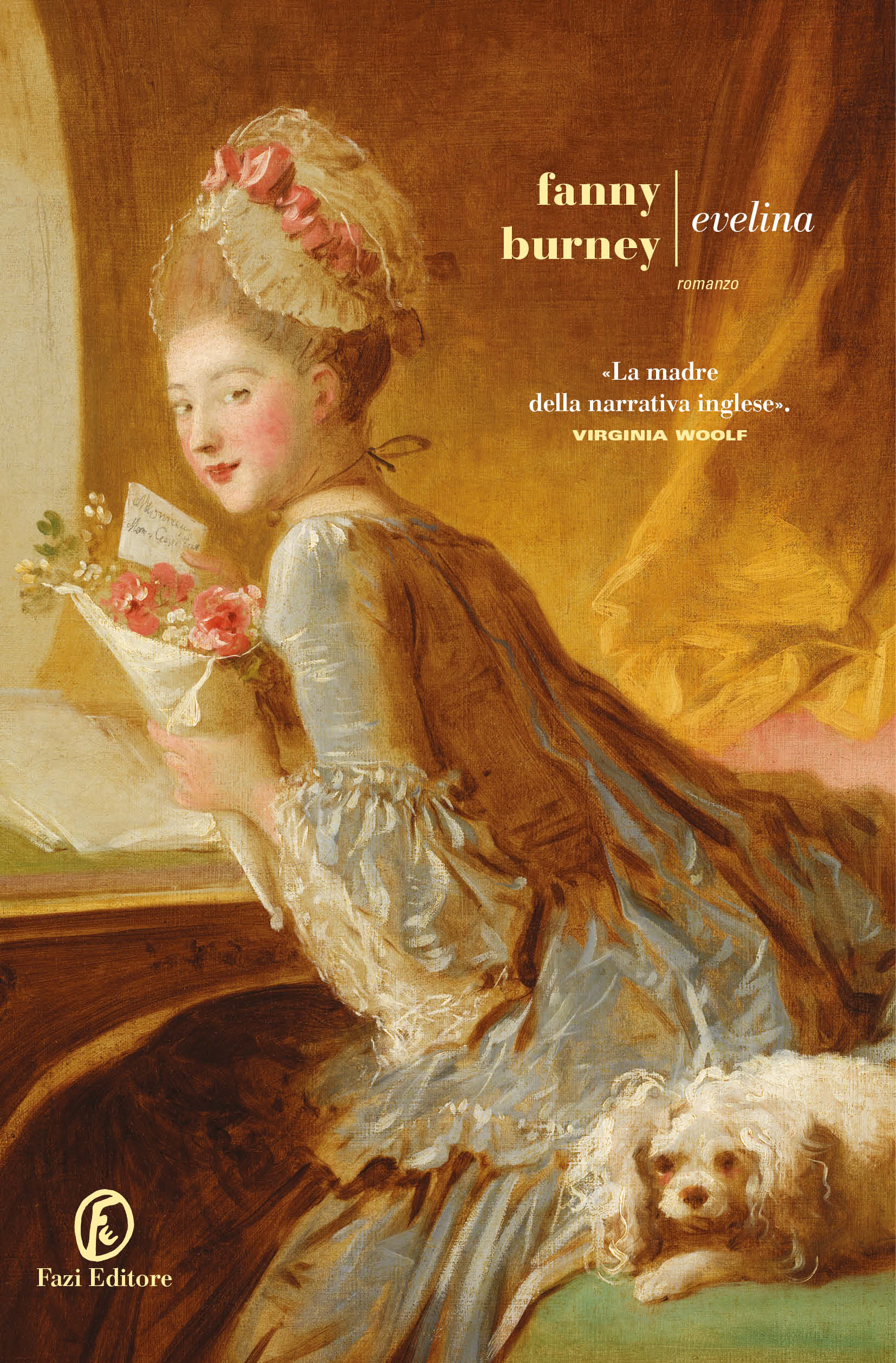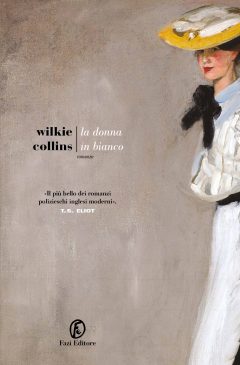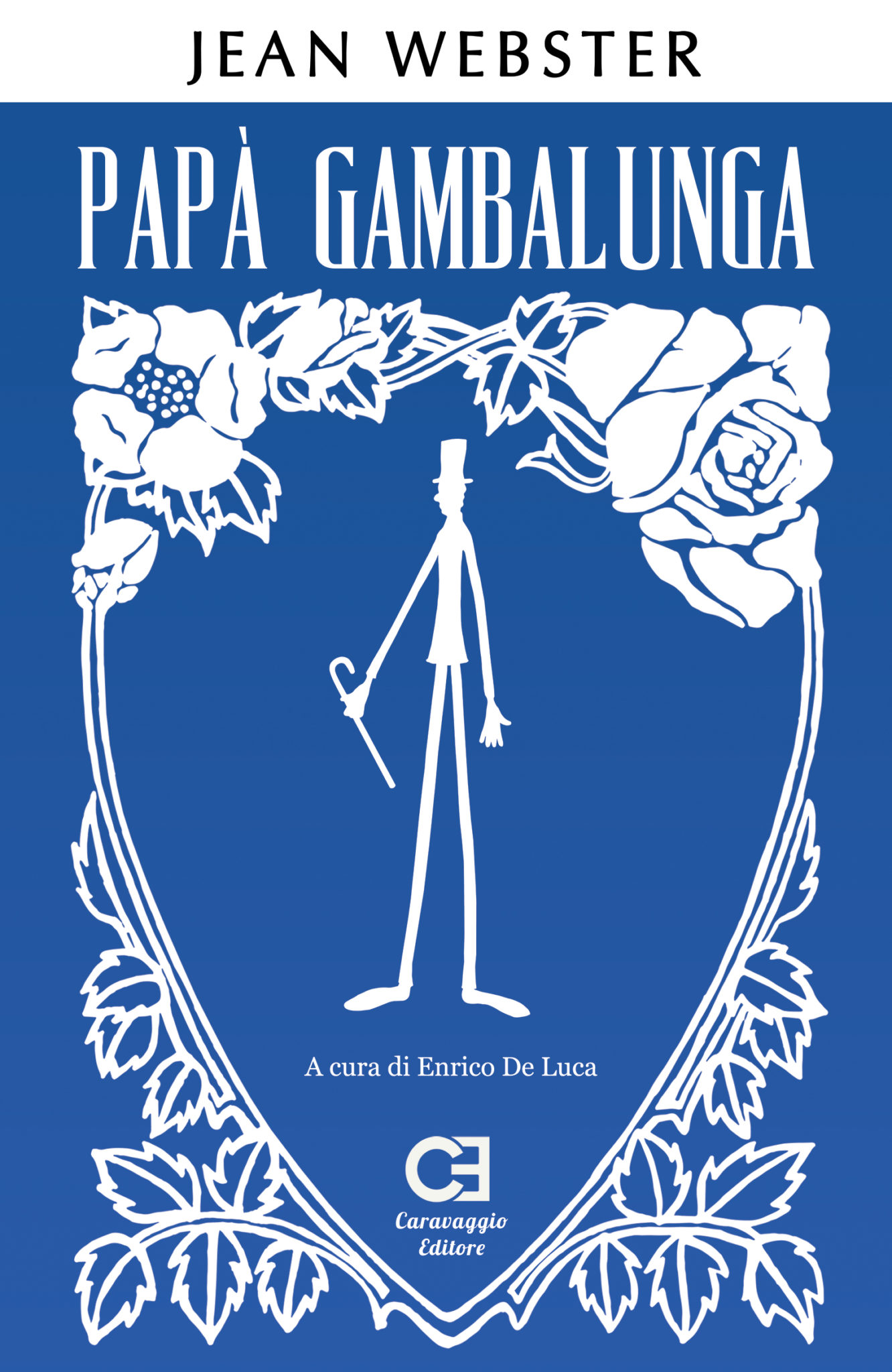
Dopo aver terminato la lettura di Papà Gambalunga mia figlia, oltre a chiedermi subito se il seguito era reperibile -ci sono vecchie edizioni in giro dal titolo Caro nemico, ma noi speriamo tanto che i traduttori e l’editore di Daddy Long-Legs portino a termine la loro opera e ci restituiscano la versione integrale e originale anche del secondo dei romanzi di Jean Webster, dedicati alla mitica Judy Abbott-, mi ha domandato quali altri romanzi epistolari potevo consigliarle.
Sulle prime in realtà ho dovuto rifletterci un momento per trovare dei titoli che evadessero il criterio indicato. Così ci è venuta l’idea di compilare una lista, breve, di libri che fossero scritti sotto forma di lettere. Premetto subito che il mio non sarà un elenco esaustivo ma semplicemente un suggerimento di libri attingendo alle mie esperienze di lettura
.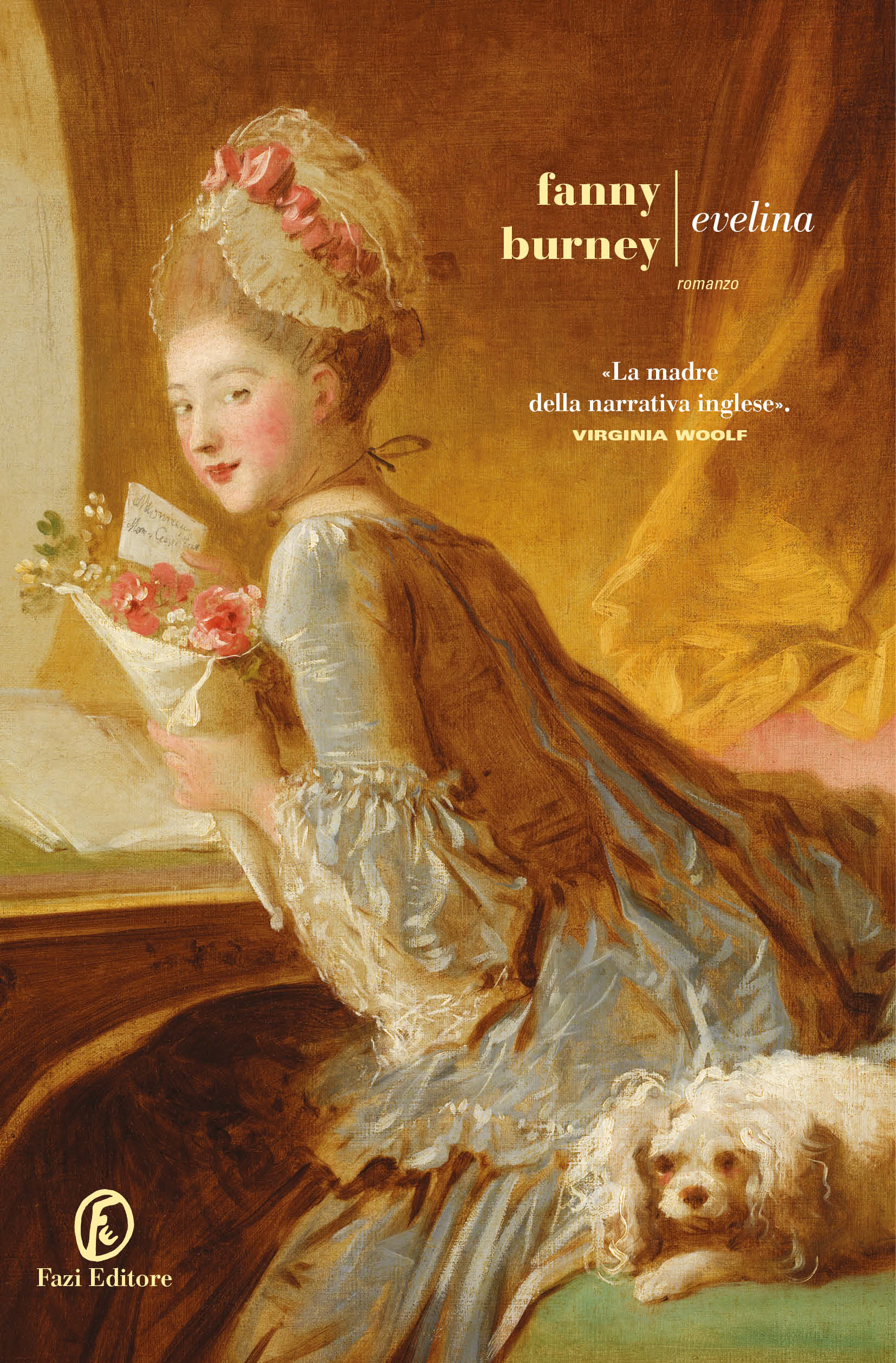
(nell’immagine Evelina appena pubblicato da Fazi Editore)
Se nel Settecento questo genere era quello più in voga, e Samuel Richardson e Fanny Burney ne sono i maestri in Inghilterra,[1] non sento di poter consigliare a una ragazzina di 14 anni i loro mastodontici volumi (tra l’altro alla monumentale traduzione de La storia di Sir Charles Grandison di Richardson si sta accingendo, avendola da poco intrapresa, Giuseppe Ierolli nel sito dedicato a Jane Austen[2], in quanto questo era considerato una delle letture preferite della scrittrice, la sua “seconda” bibbia), posso però cominciare citando alcune delle opere giovanili di quella loro ammiratrice, a sua volta piena di talento. Jane Austen ha iniziato quasi per gioco a scrivere parodiando i romanzieri famosi e tra i suoi Juvenilia, Amore e amicizia è scritto in forma epistolare, così Lesley Castle oltre che lo spassosissimo Le tre sorelle. Il suo perfetto contributo a questo genere[3], dove esprime tutta la sua maestria tra l’altro, deve considerarsi senza dubbio Lady Susan. L’arguzia dell’intreccio è esaltata dal reticolato intricato dell’epistolario che corre tra diversi destinatari e mittenti, e che ha al centro dei suoi intrighi una signora affatto timida e timorata, Lady Susan appunto. Le sue manovre, le tresche scoperte, le lettere incrociate potrebbero essere molto divertenti alla lettura, oltre che un pregevole saggio di questo stile.
Se l’epoca di Jane Austen dovesse risultare troppo datata, ma lei non lo è mai -e il film Amore e inganni[4] (per quanto stravolto nel titolo) ne costituirebbe ampia riprova-, potremmo cambiare completamente scenario con il romanzo epistolare Il Club del libro e della torta di bucce di patata di Guersney (e anche in questo caso sarebbe d’obbligo guardare la trasposizione cinematografica meravigliosa).
Non solo esso è la dimostrazione che si può parlare della seconda guerra mondiale e dell’occupazione tedesca con straordinaria soavità e levità ma anche che tutto questo sia stato realizzato tramite appunto un romanzo epistolare su cui le voci di zia e nipote, Mary Ann Shaffer & Annie Barrows, si fondono mirabilmente in un unico stile, sulla stessa scia narrativa, in uno struggente avvicendamento, necessario da parte della nipote, per l’aggravarsi delle condizioni di salute della Shaffer.

Un giorno inaspettatamente, mentre sta girando l’Inghilterra e la Scozia per la presentazione del libro appena uscito, Juliet, la protagonista del romanzo, riceve una lettera da un signore sconosciuto, che si presenta come membro del “Club del libro e della torta di bucce di patata di Guernsey”. L’occasione è troppo ghiotta perché Juliet non inizi la corrispondenza con lui e con gli altri membri del gruppo, fino ad allargarsi ad altri abitanti interpellati e coinvolti a vario titolo.
La storia dell’isola, le vicende personali di ciascun corrispondente, i loro peculiari caratteri, si impongono prepotentemente a Juliet che comincia ad avvertire un inspiegabile quanto irresistibile richiamo verso l’isola sentendosene parte e così avviene per noi dato che attraverso le lettere da loro scritte li impariamo a conoscere e ad amare uno a uno.

Devo riconoscere che quando pensavo di compilare una lista di titoli di romanzi epistolare ero partita con maggiore entusiasmo di trovarne, ma scopro di dover quasi scavalcare l’età vittoriana dove, almeno gli autori che conosco, non hanno lasciato esempi. Si potrebbe includere, sia pure con qualche forzatura, Wilkie Collins quando ne La donna in bianco si avvale della tecnica narrativa forense-giudiziario per imprestarsi la formula del processo documentale utilizzandolo come finzione narrativa avvalendosi delle deposizioni testimoniali di ciascun personaggio della storia in un incastro a puzzle. Ne esce una storia che è la risultante di un fascicolo processuale aperto su un caso misterioso e che si delinea con il racconto di alcuni dei protagonisti, secondo la loro ottica parziale e soggettiva. Ciascun contributo, con il proprio apporto e punto di vista, concorre a delineare il complessivo quadro probatorio in base al posizionamento graduale di tutte le tessere che lo compongono e che ritornano al loro posto originario.
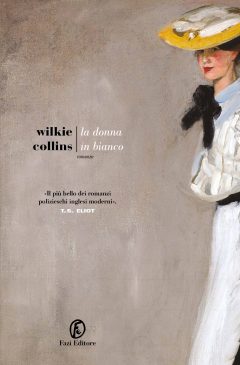
Devo registrare poi che mentre quasi tutti gli autori che conosco hanno sentito l’esigenza di sperimentare il genere gotico, o di cimentarsi in alcuni racconti di fantasmi (mi riferisco a Henry James, Edith Wharton o anche Virginia Woolf), non mi risulta che siano stati attratti dal tentare quello epistolare; eppure questo è stato sempre il metodo di comunicazione principale per scambiare notizie e coltivare le relazioni interpersonali sulla carta, esercizio quotidiano di stile e composizione, fino a diventare vera e propria arte.

Con un salto metatemporale, arrivo ai giorni nostri per citare questo libro: Lettere ad Alice che legge Jane Austen per la prima volta
.
La formula di indirizzare lettere alla nipote è utilizzata dalla zia Fay Weldon per combattere tutti quei luoghi comuni che insistono sulla scrittura di un romanzo da parte di una donna, prendendo Jane Austen come esempio. Questo pretesto viene usato per analizzare le opere e la vita cercando di trarne massime valide anche al giorno d’oggi, e nel caso specifico di Alice ai suoi primi -e sembra proprio fruttuosi- esperimenti letterari. Consigli sulla trama, su come delineare i personaggi, sulla struttura del libro, sui suoi intenti, sulla sua possibilità di accesso alla Città dell’Invenzione: non so se definire questo libro un singolare epistolario o un singolare saggio; sicuramente una conversazione -a senso unico tra l’altro- tra una zia e una nipote che non si conoscono più di tanto. L’argomento delle lettere? Dare consigli alla diciottenne Alice che vorrebbe scrivere un libro ma non ha molta voglia di leggere né di studiare e comunque trova noiosi i testi che le propinano nei corsi scolastici. E forse qualche giovane ragazza potrebbe ritrovarcisi.

Impossibile non innamorarsi dell’amore che traspare da ogni pagina della corrispondenza immaginaria tra Jane Austen e Tom Lefroy, il suo presunto primo amore, in uno stile senza tempo che Amalia Frontali ha cercare di tradurre in realtà nel suo Mia cara Jane, autopubblicato. Il progetto del libro è di riempire i tre anni che vanno dall’iniziale conoscenza tra i due alla fine della loro platonica relazione o almeno quando tra loro si sono del tutto interrotti i contatti, con una corrispondenza intercorsa segretamente. Il garbo con cui l’autrice riesce a delineare la relazione amorosa tra Tom e Jane, cercando di rendere l’insistenza impulsiva di lui e la ritrosia di lei, con lettere e dichiarazioni assolutamente romantiche, conquistano al primo impatto e trasportano in un’altra epoca storica.
Assolutamente geniale è poi un ciclo di romanzi costituito da due saghe: la saga del Sestante di Amaryllis L. Medlar, e la saga della Sposa di Amalia&Amaryllis, a loro volta composti da 4 volumi
.
(immagine di Antonia Romagnoli)
Ovviamente c’è un ordine e i romanzi tra loro sono tutti collegati ma io vorrei parlare del primo che ho conosciuto e letto e cioè Il Prezzo della Sposa, frutto di un singolare connubio letterario e definito dalle stesse autrici, un romanzo corale epistolare, dopo il quale sarà impossibile non proseguire nella lettura degli altri.
Esso inaugura la Saga della Sposa: una serie di romanzi epistolari a narrazione corale che accompagnano i numerosi personaggi, nella loro evoluzione personale e familiare, per tutta la seconda metà del XIX secolo, fra i fasti dell’Impero Russo, la notte artica di Svezia, le danze sfrenate della Puzsta, passando per la perfida Albione, fino al selvaggio West.
E rimane il più esaltante, perché da esso si sviluppano i nuclei tematici principali e la portata dell’opera trova compiuta espressione.
Nel 1870 i destini di tre famiglie s’incrociano in una tenuta non lontana da San Pietroburgo. La giovanissima Ann di Salmis, nobile svedese e provetta scacchista, stringe un’amicizia indesiderabile con il calmucco Ivan Orchadev, figlio ventenne di una famiglia di mezzadri dei Principi Kuragin.
In una narrazione epistolare corale, che esplora la polifonia dei carteggi privati fra vari membri delle tre famiglie protagoniste e di altre disseminate per l’Europa, la storia di Ann e Ivan, una partita a scacchi dopo l’altra, si dipana negli anni, affrontando gli ostacoli delle differenze di censo e della disapprovazione familiare e sociale. Li incontriamo bambini e non possiamo non innamorarcene.
Originale l’ambientazione e il modulo narrativo che sposa il genere epistolare alla tradizione del gioco degli scacchi per corrispondenza. Ciascun personaggio svela se stesso e gli altri in un gioco di specchi rifrangenti la propria immagine o la propria interpretazione dei fatti. L’incastro di date e rapporti epistolari non è solo ben riuscito ma avvincente e la lettura si è rivelata quindi una complessa ed elegante partita a scacchi, giocata in più mosse e da più giocatori, prova di intelligenza e di forza silenziosa grazie a un sublime sfoggio di arte epistolare.
Anche se lo avevo dimenticato nell’iniziale stesura di questo articolo, devo assolutamente includere nell’elenco Una donna indipendente di Elizabeth von Arnim, scrittrice che adoro e che mi sorprende sempre per il tipo di storia e di situazione che riesce a creare, sempre diversa in ogni suo libro.

La venticinquenne Rose-Marie vive a Jena insieme al padre, il professore, quando nella loro vita arriva Roger, un giovane inglese, nobile decaduto, in Germania per imparare il tedesco. I due si innamorano, Roger si dichiara, ma deve tornare in Inghilterra dalla famiglia, e le lettere che Rose-Marie gli scrive sono piene di impazienza, ansiose di avere una risposta. Ma fin dalle prime pagine è chiaro che la fedeltà di Roger si appanna velocemente: la distanza, il temperamento e le condizioni sociali rendono difficile il rapporto. Spunta un’altra donna, bella e ricchissima. Si assiste così all’altalena dell’amore tra due persone molto differenti, e la vicenda si dipana solo grazie alle lettere di Rose-Marie: quelle di Roger si possono solo immaginare dalle risposte della ragazza, ben decisa a imporre la propria volontà.
Sapete che ho desiderato spesso essere nata uomo, così da potermi infilare gli stivali e partire per esplorare questo grane mondo senza alcun impedimento; per una cosa tuttavia sono felice di essere nata donna, ossia per il fatto che è la donna a dare. Ricevere è molto meno bello. L’uomo prende sempre, la donna dà sempre; e dà in modo incondizionato, a dispetto delle più terribili sventure, disgrazie, la morte… il che forse spiega il maggior accanimento nell’attaccarsi alle sottane di una passione ormai sopita; perché il sentimento più tenero non sta forse dalla parte di chi tra i due più ha dato e si è prodigato?
Quanta dignità e poesia e verità in queste lettere di una giovane donna che scopre che può benissimo fare a meno di un uomo. E in definitiva vuole bene a se stessa e alla vita nonostante e sopra a tutto.
***

Non saprei dire esattamente quali potrebbero essere i motivi che spingono a preferire questo genere rispetto agli altri. Sicuramente la facilità e l’agilità di approccio e di lettura, perché il testo si rivela di immediata e semplice lettura il che è inversamente proporzionale alla difficoltà di saperlo produrre in tal guisa (ecco perché non è esattamente il genere più semplice da scrivere). Un altro motivo potrebbe essere rappresentato dalla possibilità di immedesimarsi completamente nel punto di vista di chi scrive la lettera e vivere gli eventi e le emozioni direttamente come accadono.
Infine, sebbene gli sia stato addebitato mancanza di realismo e di verosimiglianza rimane uno stile diretto ed espressivo che sa però diventare anche molto elegante sia nella composizione che nella lettura.
Sono molto graditi i vostri consigli per allungare questa lista. Ne aspetto tanti!
[1] Non parto da Jacopo e Werther e non cito la tradizione francese di Rousseau perché vorrei circoscrivere il discorso alla letteratura inglese che mi interessa, anche se poi nel mondo letterario tutto è collegato e reciprocamente influenzato.
[2] http://www.jausten.it/jaletturegrandison.html
[3] In realtà per l’esattezza devo precisare che anche un altro romanzi era stato scritto originariamente in forma epistolare e cioè Ragione e Sentimento che inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi Elinor and Marianne.
[4] https://ipiaceridellalettura.wordpress.com/?s=amore+e+inganni